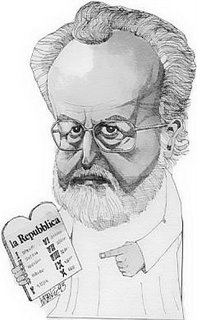Il riformista ha pubblicato un articolo del direttore, Antonio Polito, sulla necessità di un codice etico per i politici italiani, cui sta facendo seguito un dibattito aperto, soprattutto, ai simpatizzanti della sinistra.
Abbiamo notato che, tutto sommato, gl'interventi sul tema sono piuttosto banali, anche se provengono da persone intelligenti ed equilibrate come, ad esempio, Guido Bolaffi, il quale continua a ritenere valida - in linea di principio - la distinzione posta dal giornale su illecito ed illegale, la quale, a nostro sommesso avviso, è pura tautologia.
Le propensioni british e filodiessine del meridionalissimo direttore hanno forse influito, più d’ogni altra circostanza, a rendere poco meno che superficiale il dibattito, allontanandolo dal nocciolo della questione e da un pur timido tentativo di definizione, per così dire, deontologica.
Il fatto è che l'illecito e l'illegale sono pressoché sinonimi, da un punto di vista tecnico-giuridico, e, se le parole hanno un senso, non sarà l'importazione di qualche concetto anglosassone, che può servire alla bisogna.
Antonio Polito, rispettabilissimo opinion maker dell'area liberal postcomunista, ha un'evidente preoccupazione, dopo la scoperta delle magagne unipoliste e cooperativiste: quella di salvare il salvabile nell'unica sinistra, che può dirsi presentabile in Italia, quella, per l'appunto, dei DS con vocazione (inaspettatamente) socialdemocratica.
Ma, purtroppo, il compito che si è assunto è inane.
Non si può mescolare troppo il marxismo emendato dagli errori della rivoluzione con il laburismo, che ha ben altra tradizione ed introdurre specificazioni, appartenenti a campi culturalmente diversi da quelli del nostro paese o dell'area mediterranea.
E poi, per quale motivo dovremmo avere l'esigenza di adottare costumi, formule o regole, codici e comportamenti, che non siamo in grado di seguire con convinzione e spontaneità?
Ci sembra una scelta forzata dalla tendenza esterofila del quotidiano lib-lab (uno dei vizi più marcati degl'italiani), che lungi dal risolvere del problema, non fa che aumentare la confusione delle forme.
Sappiamo bene che la morale è distinta dal diritto e che la politica è una scienza sociale da non confondere con la religione, oppure no?
Machiavelli non è S. Agostino e la violazione della legge, spesso, non significa commettere peccato o trasgredire la morale comune.
La situazione italiana è grave ma non è seria, per dirla con Flaiano, e non saranno i pannicelli caldi proposti dal vivace direttore Polito a salvarci dal degrado della partitocrazia, ben oltre trentanni dopo le lucide analisi del grande costituzionalista Giuseppe Maranini, il quale aveva ben indiduato le cause degenerative del sistema (pseudo) democratico, che ci governa dal secondo dopoguerra.
Un bell'articolo di qualche anno fa di Ernesto Galli Della Loggia (se non andiamo errati) lamentava la decadenza del senso dello Stato e delle élites, sia politiche sia burocratiche, nate con il Risorgimento, consolidate dalla Destra storica e sopravvissute alle due guerre mondiali, inevitabilmente destinate a scomparire con il nuovo assetto di governo, che prese il sopravvento all'indomani degli anni sessanta, grazie alla gestione del potere da parte di movimenti ideologici, sostanzialmente estranei all'unità d'Italia.
I partiti filoclericali e quelli d'impronta marxista, in effetti, che potevano farsene di uno Stato super partes, governato dai princìpi liberali, nazionali od anche genuinamente federalisti, tesi a consentire l'ingresso delle masse, attraverso la selezione di persone al servizio della collettività e della società civile, secondo un codice etico che poneva in primo piano il disinteresse personale, come insegnavano i Sella e gli Einaudi e perfino Don Sturzo, un sacerdote dotato di spirito laico comunitario, più di tanti laicissimi rappresentanti del popolo sovrano, dediti ad aumentare i benefici propri e quelli della propria consorteria, con lo smantellamento - in nome della morale spartitoria - dello Stato e delle strutture pubbliche post-unitarie?
Le radici del male attuale provengono da una classe dirigente, connotata dall'egoismo di partito o personale, miope nel guardare al futuro del Paese, provinciale e casereccia, che ha lottizzato tutto e più di tutto, per favorire nepotes e clientes, stropicciandosene allegramente non solo dello stato e della nazione, ma anche della propria regione e del proprio comune.
Che cosa mai, a questo punto, possano insegnarci gli anglosassoni, lo sa solo Il riformista.
E perché non siamo in grado, con il patrimonio d'idee e di esperienze storiche di fare da noi il cambiamento tanto auspicato?
Provi a chiedersi Polito se i codici deontologici dei governanti inglesi o americani avrebbero potuto essere rispettati, senza il patriottismo intriso di spirito religioso, che caratterizza il diffuso sentire di quelle popolazioni ed il profondo attaccamento alla libertà e all'indipendenza delle proprie Istituzioni.
In tal modo potrà avere una buona parte di risposte alla malattia, che affligge sempre più gravemente il nostro paese, il quale, in decenni di perverso esercizio partitocratico, ha messo in soffitta tutti i punti di riferimento elevati nell'amministrazione della res publica, in nome del tornaconto privato e del longanesiano tengo famiglia.